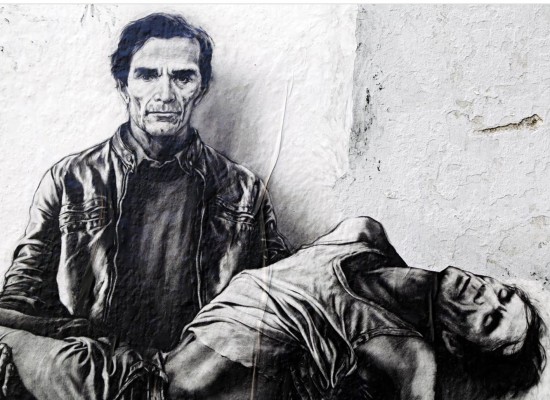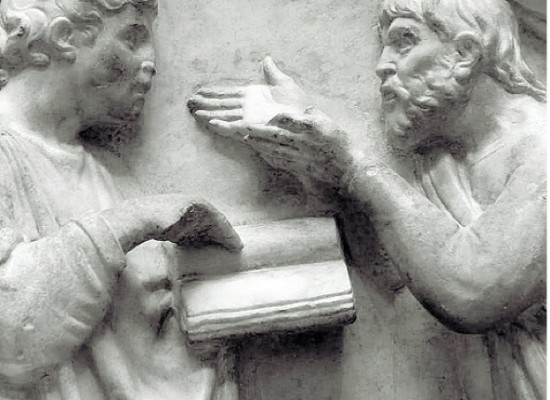Impegno a guarire senza farsi distrarre da altre attività
13/07/2023
L’azienda ha contestato al lavoratore, un operaio del settore metalmeccanico, di aver simulato un infortunio occorsogli sul luogo di lavoro, che gli aveva cagionato un trauma alla caviglia sinistra o comunque un aggravamento dello stato di malattia ed ostacolatone la guarigione, per le condotte contrarie ai doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede, specificatamente addebitate sottraendosi in modo illegittimo alla prestazione lavorativa che doveva rendere a favore del datore di lavoro, con abuso dei benefici concessi dalla legge per l’infortunio genuino, rendendosi responsabile del reato di truffa con danno dell'impresa e dell'Inail.
Il tribunale ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa ritenendo insussistente il fatto di rilevanza disciplinare. Per il tribunale è stato dirimente che il medico curante, che ha certificato lo stato di morbilità, non avesse prescritto limitazioni nei movimenti o negli spostamenti o nelle attività quotidiane ma soltanto un periodo di riposo e di cure.
La Corte di Appello di Catania è stata di contrario avviso e ha riformato integralmente la sentenza, dichiarando sussistente il fatto disciplinare con il conseguente licenziamento per giusta causa. La Corte di Appello ha accertato “ sulla base di investigazioni private datoriali nell'arco temporale contestato, come il lavoratore, nel periodo di malattia suindicato (nel quale peraltro si era sottoposto a numerose visite mediche e ad un ciclo di tre sedute di infiltrazioni di acido ialuronico…), abbia tenuto comportamenti (di protratta stazione eretta; di guida di auto, scooter o moto; di scarico e carico di scatoloni; di spazzamento del marciapiede antistante l'esercizio commerciale intestato ai familiari; di ripetuti spostamenti a piedi; di montaggio con altri di un portabagagli sulla propria vettura; di carico e scarico di materiale edile)”.
Con questi comportamenti, per la Corte di Appello, il lavoratore ha “ostacolato e comunque ritardato la guarigione, in violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede, integrante giusta causa di recesso datoriale”.
La Cassazione, intervenendo nella controversia su ricorso del lavoratore, ha respinto il ricorso affermando i seguenti principi:
“è noto che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configuri violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore nel tempo della sua assenza dal lavoro per malattia o per infortunio ha il “dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia”.
Su chi debba dare la prova davanti ai giudici della sussistenza del fatto disciplinare, la Cassazione ha sottolineato che “E’ parimenti risaputo che, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, gravi sul datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, atteso che la L. n. 604 del 1966, art. 5 pone a carico del datore l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato”. Cassazione civile sez. lav. - 12/05/2023, n. 12994.
Nel caso in esame il datore di lavoro, per la Corte, ha assolto questo obbligo perché ha dato prova dei fatti contestati al lavoratore sulla base delle investigazioni private datoriali eseguite nei giorni di assenza per malattia.
Per la giurisprudenza della Cassazione, nei giorni di assenza per malattia o per infortunio, il lavoratore ha l’obbligo di dedicarsi con impegno a guarire, senza prestare attività, per sé o per altri, che possano in qualsiasi modo pregiudicare o ritardare la sua guarigione e il suo previsto rientro in azienda. Non ha rilevanza che, nonostante queste attività, sia rientrato poi in azienda alla scadenza dell’originaria certificazione medica, perché il pericolo del ritardo nella guarigione deve essere valutato ex ante , in astratto e preventivamente.
Lo studio a Milano
Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto
Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti
DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE
GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO
La disabilità nei rapporti di lavoro
 Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)