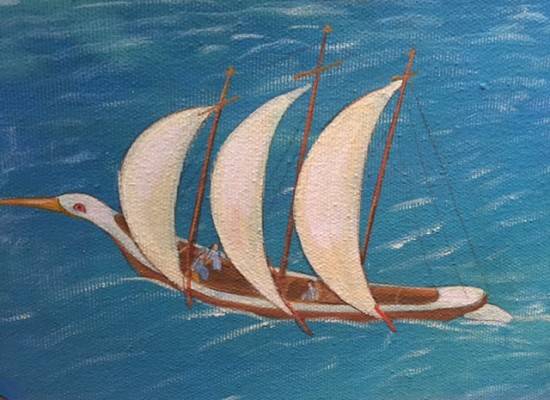Licenziamento per ritorsione: fondamentale l’applicazione dei principi comunitari
08/01/2016
Nel caso in esame, un lavoratore ha impugnato il licenziamento intimato per giusta causa, qualificandolo come ritorsivo e comunque illegittimo. In particolare, il lavoratore aveva predisposto e consegnato ad uno dei consiglieri di amministrazione della società, su sua richiesta, una relazione contenente accuse di infedeltà patrimoniale e critiche all’operato dei vertici della società, i quali hanno, quindi, addebitato al lavoratore un comportamento specifico di infedeltà, ritenendo le accuse mosse false e gravemente denigratorie. In riforma parziale della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Milano non ha ravvisato la sussistenza del carattere ritorsivo del licenziamento, ritenendolo comunque illegittimo e riconoscendo al lavoratore, peraltro, il risarcimento del danno ulteriore per le modalità ingiuriose di adozione del licenziamento: l’azienda, infatti, aveva inviato a duecento soggetti, con i quali la società era in contatto, una missiva con l’anticipazione dell’imminente licenziamento del ricorrente.
 Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore. La Suprema Corte, in particolare, ha stabilito che “l'esclusione del carattere ritorsivo del licenziamento sia stata il frutto di un evidente errore di diritto, in quanto la Corte ambrosiana, sulla base di una definizione del licenziamento ritorsivo del tutto "originale" e priva di riscontri normativi e/o giurisprudenziali, non ha adeguatamente valorizzato gli elementi della fattispecie dai quali, inequivocamente, si desume il carattere ritorsivo del recesso.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore. La Suprema Corte, in particolare, ha stabilito che “l'esclusione del carattere ritorsivo del licenziamento sia stata il frutto di un evidente errore di diritto, in quanto la Corte ambrosiana, sulla base di una definizione del licenziamento ritorsivo del tutto "originale" e priva di riscontri normativi e/o giurisprudenziali, non ha adeguatamente valorizzato gli elementi della fattispecie dai quali, inequivocamente, si desume il carattere ritorsivo del recesso.
In tal modo la Corte territoriale si è discostata dai consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte, secondo cui:
a) il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta — assimilabile a quello discriminatorio — costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni (Cass. 8 agosto 2011, n. 17087);
b) il divieto di licenziamento discriminatorio — sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990 - è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa, essendo necessario, in tali casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. 18 marzo 2011, n. 6282, in senso analogo: Cass. 27 febbraio 2015, n. 3986)”.
In più, per la Cassazione, il giudice d’appello non ha neppure considerato il lungo processo evolutivo che l’ordinamento comunitario ha avuto nel corso degli anni in materia di diritto antidiscriminatorio ed antivessatorio, nei riguardi, specialmente, dei rapporti di lavoro e del licenziamento per ritorsione. Questo sviluppo ha portato, nel corso del tempo e principalmente per effetto del recepimento di direttive comunitarie, alla conseguenza che “anche nel nostro ordinamento condotte potenzialmente lesive dei diritti fondamentali di cui si tratta abbiano ricevuto una specifica tipizzazione - pur non necessaria, in presenza dell'art. 3 Cost. - (Corte cost. sentenza n. 109 del 1993) - come discriminatorie.”
Per la Suprema Corte, il carattere vendicativo del licenziamento è dimostrato ictu oculi dalla coincidenza tra i soggetti destinatari della relazione negativa predisposta dal lavoratore e coloro che hanno irrogato il licenziamento, oltretutto con modalità ingiuriose come ha riconosciuto la stessa Corte d'appello.
Per tali motivi, riconoscendo nella fattispecie un licenziamento per ritorsione, la Suprema Corte ha condannato la società alla reintegra del lavoratore ed al risarcimento del danno. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 29 settembre – 3 dicembre 2015, n. 24648)
Nella foto: opera di Vladimir Stefanovic Tarasenko. Operaie di elettronica al lavoro. 1976. olio su tela.