Rimettere le sentenze sulla consolle del processo telematico
31/12/2018
Un patrimonio perso per ragioni oscure
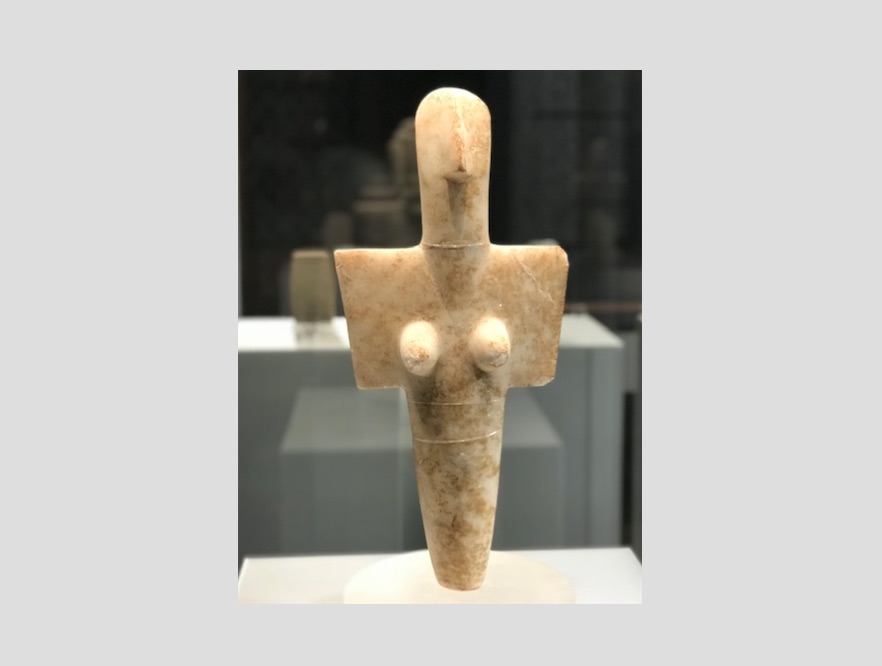 Sulla consolle del processo telematico, fin della sua creazione, e via via negli anni, sono state pubblicate le sentenze civili dei Tribunali e delle Corti di Appello. Il risultato finale è stato quello di aver creato una sezione molto ricca che, nel tempo, si è accresciuta. La pubblicazione delle sentenze civili ha rappresentato per noi avvocati un'utile fonte di informazione giurisprudenziale alla quale attingere per conoscere l'orientamento non solo dei tribunali e delle Corti d'Appello ma anche di quel singolo giudice o di quel collegio giudicante. Si trattava di una fonte informativa che in passato non ha mai avuto un equivalente, per potenza e completezza. Poter attingere con facilità ed immediatezza a questa fonte proiettava l'attività dell'avvocato in una dimensione moderna che arricchiva le sue conoscenze. Anche i giudici ne traevano vantaggio perché si relazionavano con avvocati sapienti. Grazie a avvocati conoscitori degli orientamenti giurisprudenziali dei singoli giudici sulle varie questioni giuridiche a loro sottoposte, si possono gestire meglio le controversie e anche le soluzioni conciliative.
Sulla consolle del processo telematico, fin della sua creazione, e via via negli anni, sono state pubblicate le sentenze civili dei Tribunali e delle Corti di Appello. Il risultato finale è stato quello di aver creato una sezione molto ricca che, nel tempo, si è accresciuta. La pubblicazione delle sentenze civili ha rappresentato per noi avvocati un'utile fonte di informazione giurisprudenziale alla quale attingere per conoscere l'orientamento non solo dei tribunali e delle Corti d'Appello ma anche di quel singolo giudice o di quel collegio giudicante. Si trattava di una fonte informativa che in passato non ha mai avuto un equivalente, per potenza e completezza. Poter attingere con facilità ed immediatezza a questa fonte proiettava l'attività dell'avvocato in una dimensione moderna che arricchiva le sue conoscenze. Anche i giudici ne traevano vantaggio perché si relazionavano con avvocati sapienti. Grazie a avvocati conoscitori degli orientamenti giurisprudenziali dei singoli giudici sulle varie questioni giuridiche a loro sottoposte, si possono gestire meglio le controversie e anche le soluzioni conciliative.
Improvvisamente, tutte quelle sentenze civili, caricate nel sistema informatico in tanti anni di lavoro, sono scomparse: letteralmente cancellate dal sistema, non si vedono e non si consultano più. Abbiamo pensato che si trattasse di un momentaneo problema dovuto al cattivo funzionamento del software o dell'hardware. Abbiamo sperato che da un momento all'altro la funzione venisse ripristinata. Sono passati mesi, ma ogni speranza è stata vana. Abbiamo cercato di capire il perché della perdurante assenza della pubblicazione delle sentenze, ma, da chi doveva fornire informazioni, abbiamo avuto risposte con spiegazioni incerte e vaghe. Da ultimo abbiamo appreso che la soppressione di quella intera sezione della consolle del processo telematico dedicata alla pubblicazione delle sentenze civili era dovuta a non meglio specificati problemi di "privacy". Per quanti sforzi intellettivi si possano fare, sinceramente, non abbiamo capito le ragioni del richiamo a questo concetto salvifico della "privacy" che, nel nostro caso concreto, è del tutto fuori luogo. Le sentenze sono pubbliche, lo dice espressamente l'articolo 133 del codice di procedura civile; il sistema del processo telematico consente l'accesso solo agli addetti ai servizi (avvocati muniti di password, personale di cancelleria e giudici). La motivazione della privacy è ancora più risibile e umoristica sol che si pensi che nel contempo la Corte di Cassazione, nel suo sito, accessibile a tutti, pubblica da anni, e per intero, le sentenze con nome e cognome delle parti, con la narrativa dei fatti e delle ragioni della decisione. È ben strano un sistema giuridico che senta l'esigenza di dover tutelare con il richiamo alla privacy la mancata pubblicazione delle sentenze dei tribunali e delle Corti di Appello riservata agli addetti ai lavori, mentre nel contempo, l'organo supremo della giurisdizione, la Corte di Cassazione, dà il massimo di pubblicità alle sue decisioni pubblicandole giornalmente e con adamantina puntualità sul proprio sito Internet. Ha ragione la Corte di Cassazione che pubblica le sue sentenze o chi ha deciso di non pubblicare più sulla consolle le sentenze dei giudici di merito?
Conoscere la giurisprudenza dei giudici di merito costituisce un enorme e fondamentale contributo alle conoscenze e alla formazione professionale di tutti gli operatori del diritto e contribuisce a semplificare e ridurre il contenzioso giudiziario.
Chiediamo che quella funzione sia ripristinata per intero e con immediatezza. La conoscenza è ricchezza al servizio della collettività; non può essere umiliata o compressa perché migliora tutti. La pubblicazione è anche espressione di democrazia perché consente il controllo dell'esercizio dell'attività giurisdizionale.
È stata inviata una petizione al Ministero della Giustizia, all’Ordine degli avvocati di Milano e alle varie associazioni forensi ma senza risultato. Tutto tace.
La foto: dalla mostra Idoli, il potere dell'immagine, Venezia Palazzo Loredan.
 Il patto di prova, contenuti e forma
Il patto di prova, contenuti e forma
In occasione della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, le parti possono ben convenire che l’assunzione avvenga con il patto di prova. Inserire in un contratto di lavoro questo patto significa che il datore di lavoro e il lavoratore prima della scadenza del termine finale della prova, possono decidere di sciogliersi liberamente dal contratto. Lo scioglimento può avvenire dall’oggi al domani, senza alcuna conseguenza negativa per il soggetto che assume l’iniziativa di farlo. Chi si scioglie dal rapporto di lavoro non deve dare alcun preavviso e non deve pagare alcuna indennità sostitutiva. Il datore di lavoro non deve dare la prova della sussistenza di un giustificato motivo o di una giusta causa per poter intimare il licenziamento.
Il patto di prova, però, per essere valido e produrre gli effetti che abbiamo indicato, richiede dei requisiti di forma e di sostanza che possiamo così sintetizzare. Innanzitutto, il patto di prova deve essere concluso in forma scritta. Questa forma è un elemento essenziale. Se le parti dovessero stipulare il patto in forma verbale quel patto sarebbe semplicemente nullo. Non vale niente, come se non fosse mai stato concluso e voluto dalle parti. La nullità del patto di prova significa che il rapporto di lavoro è diventato definitivo e per essere risolto per iniziativa dell’azienda occorrono i rigorosi requisiti previsti dalla legge sulla giustificazione del licenziamento.
Un ulteriore requisito essenziale per la validità del patto di prova è costituito dalla indicazione delle mansioni che dovranno essere oggetto della prova. Le mansioni devono essere ben individuate e specificate nella lettera di assunzione. Le mansioni possono essere individuate anche con il semplice richiamo al contratto collettivo e all’inquadramento. Ma il contratto collettivo così richiamato deve fornire una conoscenza certa delle specifiche mansioni che dovranno essere oggetto della prova e che il lavoratore è chiamato a svolgere. Se il contratto collettivo in quel livello dovesse prevedere diversi profili professionali, la validità del patto di prova è seriamente compromessa.
Nei mesi o nei giorni della prestazione lavorativa, il lavoratore deve essere effettivamente adibito alle mansioni indicate nella lettera di assunzione. Lealtà esige che le mansioni svolte per provarsi reciprocamente debbano essere quelle volute e indicate nell’atto sottoscritto dalle parti.
La durata della prova varia da contratto collettivo a contratto collettivo e con riferimento al livello di inquadramento attribuito al lavoratore. Più alto è il livello più lungo può essere il patto di prova. La prova di un quadro ha necessità di un periodo di reciproca osservazione più lungo rispetto ad un operaio chiamato a svolgere mansioni semplici e ripetitive. La durata massima non può superare i sei mesi. La durata della prova può essere inferiore rispetto a quella indicata dal contratto collettivo ma non può superare la durata massima prevista dal contratto collettivo.
Il patto di prova può essere inserito anche in un contratto a tempo determinato oppure in un contratto a part time o anche in un contratto a part time e a tempo determinato. La durata della prova in un contratto a tempo determinato può essere più contenuto temporalmente rispetto a un contratto a tempo indeterminato. Per conoscere l’effettiva disciplina bisogna sempre far riferimento al contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.
Concluso il contratto le parti hanno l’obbligo di esperire la prova per un congruo termine di reciproca osservazione. Lo esige la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Un patto di prova ben fatto non fa sorgere problemi nel caso in cui l’azienda prima della scadenza del termine decida di risolvere il rapporto di lavoro. Nel caso in cui il patto dovesse essere nullo e l’impresa dovesse occupare più di 15 addetti, al lavoratore illegittimamente licenziato spetta un risarcimento del danno che va da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Se l’impresa è di dimensioni più contenute il risarcimento va da due a sei mensilità della retribuzione. In tutti i casi la retribuzione mensile si calcola facendo riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del tfr. Nella realtà sono frequenti i casi di nullità del patto di prova per assenza dei requisiti che abbiamo indicato. I principi sono chiari ma la loro esistenza non sempre è ben conosciuta da chi nell’azienda gestisce le assunzioni e conclude i contratti di lavoro.